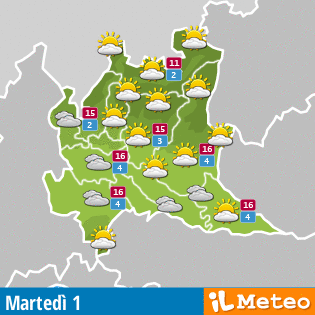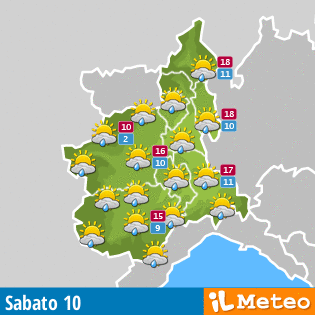I giudici d’appello hanno verificato «la certezza fattuale di ogni singolo elemento addotto dall’accusa», per arrivare «con logicità e congruenza di argomenti alla conclusione che i dati indiziari non hanno alcun grado di certezza in fatto e nessuna valenza intrinseca, perchè frutto di presunzioni e congetture».
Lo scrive la Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza con cui lo scorso 27 gennaio ha confermato l’assoluzione in via definitiva di Stefano Binda per l’omicidio di Lidia Macchi, la giovane uccisa con 29 coltellate nel gennaio 1987 e il cui corpo è stato ritrovato in un bosco del Varesotto. Un caso che a distanza di oltre tre decenni è rimasto senza colpevoli.
Binda era stato arrestato nel gennaio 2016 e condannato all’ergastolo dalla Corte di Assise di Varese il 24 aprile 2018, ma la Corte di Assise di Appello di Milano il 24 luglio 2019 aveva ribaltato le conclusioni e l’aveva assolto. La sentenza d’appello prese atto di un alibi di Binda per la sera in cui Lidia è morta. E ha ritenuto non dimostrato l’assioma per il quale la poesia «In morte di un’amica», spedita il giorno del funerale e considerata dall’accusa la prova regina, fosse stata scritta dall’assassino, tantomeno che l’avesse scritta Binda.
Nella sentenza con cui ha confermato quella decisione, la prima sezione penale della Cassazione, replicando ai motivi di ricorso della procura generale, ricorda che «Le tracce biologiche sulla busta con cui fu spedita ai familiari di Lidia Macchi la poesia «In morte di un’amica» non appartengano all’imputato, il che non è per nulla marginale».
Così come non sono sue nemmeno le tracce rinvenute sulla salma dopo la riesumazione: e questo, sottolinea il collegio, «è un risultato di prove a favore» di Binda. Per la Corte gli elementi indiziari sono stati «valutati con rigore logico e correttezza di metodo» e le conclusioni sono motivate con «adeguatezza e completezza».